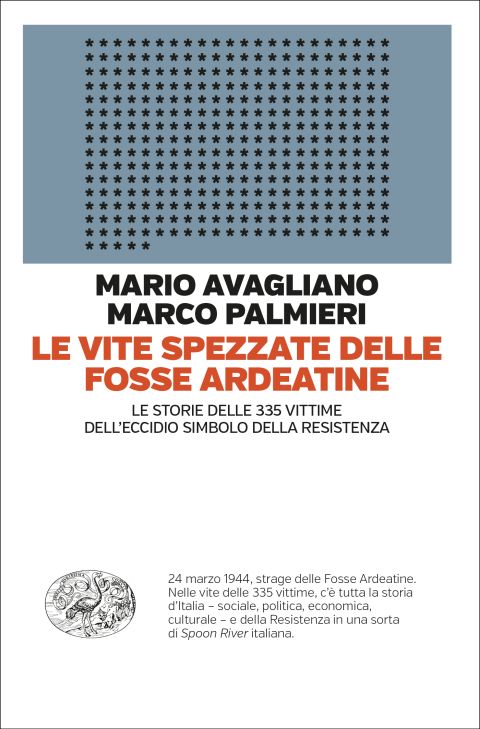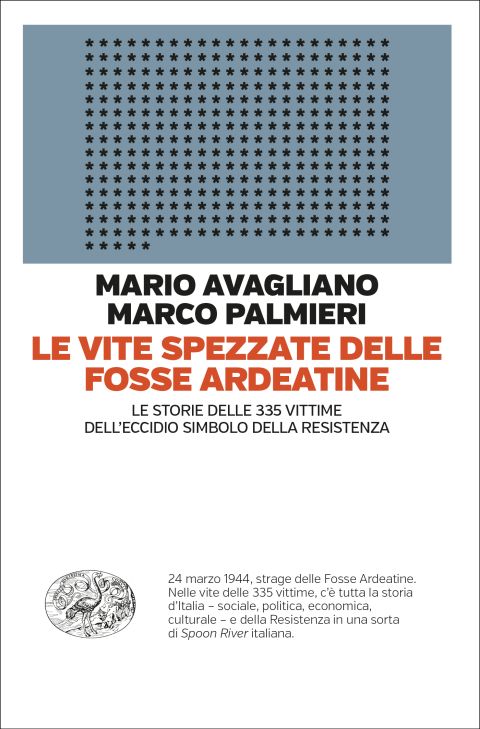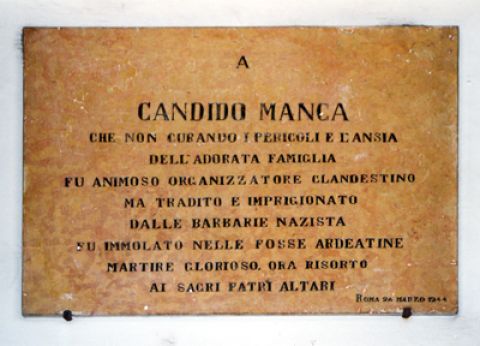di Andrea Manzella
1. Questa di Avagliano e Palmieri (Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile, Il Mulino) è una narrazione puntiforme della tempesta perfetta che si abbattè sul Mezzogiorno d’Italia nei venti mesi tra il 1943 e il 1945. Da essa si possono ricavare - intrecciate tra loro nel tempo, ma autonome nella loro sostanza - tre storie: una storia politica, una storia militare, una storia sociale. La storia politica è quella della “King’s Italy” - come la chiamarono gli Alleati - del Regno del Sud (secondo la formula del libro pioneristico di Agostino degli Espinosa, 1946). Comincia, come molte vicende di quel tempo, a Radio Bari, da dove l’11 settembre parlò il Re, fuggito da Roma: «per la salvezza della Capitale e per potere pienamente assolvere i miei doveri di Re, col Governo e con le Autorità militari, mi sono trasferito in altro punto del sacro e libero suolo nazionale». Il territorio “nazionale” era ridotto alle province di Bari, Lecce, Brindisi, Taranto : lasciate formalmente “libere” dagli Alleati. La gran parte dei ministri del governo Badoglio era rimasta a Roma. I superstiti si riunirono in Vaticano, per l’ultimo Consiglio dei ministri : per autosciogliersi. A Brindisi e sparpagliato tra varie località pugliesi, vi era, in sostituzione, un “governo di sottosegretari” (p. 155). Le condizioni operative sono più che precarie. Mancano perfino i dattilografi. Badoglio è costretto a scrivere a mano le comunicazioni ufficiali da consegnare agli Alleati. Eppure non è una “parvenza” di Stato. È il punto simbolico di legittimità a cui guarderanno le poche forze armate che non si sono arrese, i 600 mila prigionieri avviati in Germania, la flotta che amarissimamente si consegna a Malta (dopo la perdita della corazzata “Roma”), ma anche i cadetti dell’Accademia di Marina che fuggono su un mercantile da Venezia per raggiungere fortunosamente Brindisi. È anche il “territorio” statuale in cui sarà possibile che nuovi partiti politici potranno cominciare a pensare a come rinnovare lo Stato. Paradossalmente quella precaria “continuità” dello Stato è la premessa della sua ri-costituzione. Il Congresso di Bari del 28-29 gennaio 1944 è giustamente salutato dalla Gazzetta del Mezzogiorno come il «primo congresso antifascista dell’Europa liberata» (p. 146). Nel discorso di Michele Cifarelli che l’introdusse, come in quello di Benedetto Croce che avviò il dibattito vi è questa consapevolezza “europea”. «All’Italia prima terra d’Europa liberata» - dirà Croce - «gli altri paesi europei guarderanno come il saggio della loro nuova vita». Ma soprattutto nel Congresso si pongono le premesse delle “Costituzioni provvisorie” che - nella dialettica continuità/rinnovamento - si susseguiranno sino al 2 giugno 1946. Senza interruzioni della legalità vigente, si arrivò alla “rivoluzione” dello Stato repubblicano. Queste premesse costituzionali si trovano ancora una volta nella denuncia di Croce a quel Congresso: fino a che il Re rimane «noi sentiamo che il fascismo non è finito, che ci rimane attaccato addosso». Eppure quel Congresso fondativo era stato all’inizio proibito dai “governatori” occupanti. Ma una significativa mobilitazione internazionale, dei laburisti nel Regno Uniti e dei democratici negli Stati Uniti, avevano superato le resistenze dei militari. Questi riusciranno però ad impedirne la radiocronaca. Una registrazione arrivò però ugualmente alla BBC e a Radio Londra. Quel Congresso italiano d’avanguardia fu così conosciuto in tutto il mondo. Dopo il regime del “partito unico” - e ancora nell’ “anello di ferro” in cui era mantenuta quella parte d’Italia (è il lamento di Badoglio a Roosevelt, p. 173) - nasce lo “Stato pluralistico dei partiti”. La prima a riconoscerlo è la Russia sovietica. Dopo un incontro di Badoglio con Vyšinskij, l’URSS è la prima nazione a ristabilire le relazioni diplomatiche con l’Italia, già il 13 marzo 1944. Il primo ambasciatore italiano a Mosca è Pietro Quaroni. Per un suo articolo “non ortodosso” sulla politica etiopica fascista, era stato inviato per punizione in Afghanistan. Nel caos del mondo si trova così ad essere il diplomatico, leale allo Stato monarchico, più vicino al confine russo, lungo il fiume Amur. Due settimane dopo, ritorna Togliatti da Mosca. È il punto preciso del tempo in cui veramente rinasce il Partito comunista italiano fino allora una «galassia di corpuscoli divisi tra loro» (p. 160). Un acutissimo scrittore inviato di guerra, Norman Lewis, annota subito profeticamente: «ci sono tutte le premesse perché il partito diventi il più forte partito comunista al di fuori dell’URSS», proprio perché «annovera un’alta percentuale di intellettuali borghesi». Gli inglesi e gli americani, invece, ci faranno aprire le ambasciate a Londra e Washington solo il 28 settembre, sei mesi dopo dell’URSS (p. 201). Eppure l’Italia è “cobelligerante” dal 13 ottobre 1943. Da quando ha dichiarato la guerra alla Germania. Ma all’apertura sovietica, all’atteggiamento tutto sommato amichevole degli USA, corrisponde una tenace resistenza di Winston Churchill per il mantenimento dell’immobilismo nella situazione italiana. «Sono certo - dirà con il suo consueto realismo - che il Re e Badoglio sarebbero in grado di fare per noi più di qualsiasi governo italiano formato da esuli e avversari del regime fascista». E poi, il 22 febbraio 1944, nel “discorso della caffettiera” andrà oltre: sostenendo che l’unico governo possibile era quello di Badoglio perché «quando occorre tenere in mano una caffettiera bollente è meglio non rompere il manico finché non si è sicuri di averne un altro ugualmente comodo e pratico». La furibonda reazione a queste parole da parte dei partiti italiani - pur repressa nelle intenzioni di sciopero generale - è però tale da attestare che anche il manico della caffettiera di Churchill è divenuto incandescente. Il 24 aprile 1944, infatti, è la «svolta di Salerno». Il Re Vittorio Emanuele ha accettato di ritirarsi appena liberata Roma. Ma intanto è lui, a Ravello, che riceverà nelle sue mani il giuramento del II governo Badoglio: con Croce, Togliatti, Gullo, Aldisio, e perfino il repubblicano conte Sforza. Dopo la liberazione di Roma (con la ritirata tedesca ordinata da Hitler: per preservare il “centro di civiltà più antico del mondo”, p.187) il tempo di Badoglio sarà però anch’esso scaduto. Nasce il governo Bonomi con tutti i partiti antifascisti. Ma il maresciallo esautorato avrà modo di “cantarla” duramente ai “nuovi venuti”: «mentre voi eravate nascosti o chiusi nei conventi, chi ha lavorato, assumendo le più gravi responsabilità, è quel militare che non appartiene a nessun partito». La protesta più rabbiosa è però quella, coerente, di Winston Churchill che in un telegramma a Roosevelt, accusa gli alleati di aver sostituito Badoglio con un «gruppo di anziani e affamati politicanti» (p. 200). La macchina della politica nazionale si era però ormai messa in moto. L’Italia procedeva verso la riunificazione proprio mentre in Sicilia iniziava la gravissima crisi del separatismo. La “questione regionale” si apriva, in un certo senso distorto, non solo in Sicilia: e non sarà veramente risolta fino ai giorni nostri.
2. Lo stesso assetto costituzionale del nuovo Stato sarà infatti condizionato dalla storia sociale del Regno del Sud. I moti siciliani che hanno il loro epicentro nella “strage del pane di Palermo” (repressa nel sangue dai militari della divisione Sabauda, comandata dal generale Castellano, lo stesso dell’armistizio di Cassibile); e i moti sardi scoppiati a Sassari (con protagonista il giovanissimo Enrico Berlinguer, imprigionato per cento giorni) (pp. 319-321) sfoceranno alla fine nei due Statuti speciali, anteriori alla Costituzione repubblicana. Nel retroscena siciliano, poi, vi era stata quella che sembra la prima “trattativa Stato-mafia”, condotta proprio dal generale Castellano, che, con i suoi “buoni” rapporti, riuscì ad ottenere l’appoggio dell’“alta mafia” contro il dilagante fenomeno del banditismo (l’ «ora basta!» di don Calogero Vizzini, p. 337). Si “riconosceva” dunque l’egemonia di di un “potere altro”: anche se dai loro rapporti risulta che la mafia fu più un problema per gli Alleati (la cui origine era attribuita agli “interpreti” italo-americani che si erano portati dietro) che non la risorsa che favorì l’invasione militare, di cui a lungo si favoleggiò (p. 329). L’epilogo istituzionale del regionalismo “speciale” rappresenta, almeno da questo angolo visuale, quasi un attestato della singolare esperienza meridionale, segnata da tragedie individuali e collettive, provocate dalle due successive occupazioni militari. Avagliano e Palmieri ne fanno un resoconto minuto, localizzato e spesso personalizzato. Emergono i misfatti tedeschi: con la loro cieca applicazione di una sorta di diritto di guerra in rappresaglie e rastrellamenti di lavoratori coatti per la loro macchina bellica, affamata di uomini. Emergono i misfatti degli Alleati, originati piuttosto da criminalità comune nelle loro fila: ma anche con barbare uccisioni di gruppi di prigionieri di guerra italiani nei primi giorni dell’invasione siciliana e anche -e sopratutto- con quel generale diritto di stupro e di vendetta che i comandanti francesi consentirono alle loro truppe africane. Il dramma delle donne “marocchinate” provocò la protesta ufficiale del pur flebile governo Bonomi. E fu un enorme contributo alla efficacia della propaganda fascista dal Nord.
3. La storia militare di quegli anni è indistricabile da questa scia di profondo perturbamento sociale, così come dagli sforzi di ricostruzione politica. Quando alle 18.15 del 18 agosto 1943 Badoglio ed un redivivo Vittorio Emanuele Orlando si rivolgono da Radio Roma ai “fratelli siciliani” invasi, dalle loro parole traspare già la rassegnazione all’inevitabile-sconfitta. L’evacuazione dell’isola è avvenuta perfettamente il giorno prima: è stato uno stupefacente capolavoro militare tedesco. Nello stretto di Messina, grazie a un efficacissimo fuoco antiaereo dalle due sponde, si sono ritirati in Calabria più di centomila uomini (60mila italiani, 40mila tedeschi) e migliaia di tonnellate di materiale bellico. Ma i tedeschi già apprestano le loro successive linee difensive nella Penisola: l’ “ordine” militare contro il disordine dell’impotenza . Tuttavia, quando Badoglio e il Re si ritroveranno nel “ridotto” delle quattro province pugliesi, il loro primo sforzo è quello di riorganizzare un primo nucleo militare che attestasse - nell’unico modo concreto consentito in quelle condizioni - una continuità simbolica dello Stato monarchico. Già il 24 settembre (mentre il Re proclama da Radio Bari la lotta contro «l’inumano nemico della nostra razza e della nostra civiltà»: parole surreali in quanto riservate ad un alleato di appena 16 giorni prima) si costituisce una unità motorizzata di 5 mila uomini (p. 346). È l’inizio della “cobelligeranza”: accolta con estrema freddezza dagli Alleati (nonostante gli sforzi ripetuti di Badoglio, che scrive ad Eisenhower: «abbiamo chiesto l’armistizio perché deboli ma non siamo dei poltroni» ed arriverà ad offrire le sue dimissioni nel caso che l’ostacolo al riarmo fosse stata la sua persona, p. 354). Il “battesimo del fuoco” sarà a Montelungo il 26 novembre: una piccola vittoria, dal grande significato, pagato a carissimo prezzo, 82 caduti e 160 dispersi. È a Scapoli, paesino del Molise, che le unità militari del Regno del Sud, assumeranno il nome di Corpo italiano di liberazione. Gli Alleati faranno tornare dalla onorevole prigionia in Tunisia il maresciallo Messe, non compromesso dunque con il disastro della dissoluzione militare dopo l’armistizio. Sarà il nuovo capo di Stato maggiore. Alla fine del conflitto il Corpo - che opererà sul versante adriatico con i polacchi del generale Anders - avrà 200 mila uomini e conterà 8100 caduti (p. 356). Accanto alla ricostituzione di una entità militare “regolare”, il Regno del Sud vedrà tentativi di volontariato, in un certo senso politico: tentativi nettamente stroncati dagli Alleati. Sarà Benedetto Croce a redigere e firmare, già l’11 ottobre 1943, un “manifesto per la chiamata di volontari” (p. 349). Ci sarà anche, più tardi, nel luglio 1944, un appello di Togliatti. In realtà i volontari, nonostante tutto, affluiscono in buon numero in un campo allestito a Cesano. Non troveranno né equipaggiamento né inquadramento. Rabbia e ribellione accoglieranno, invece, soprattutto in Sicilia, i bandi militari di leva del governo Badoglio. «Non vogliamo andare contro i nostri fratelli del Nord»: il movimento “Non si parte” vedrà uniti separatisti e neofascisti. A Comiso questo eterogeneo connubio fonda addirittura una sedicente repubblica indipendente. Durerà una settimana: sotto minaccia militare la “repubblica” si arrende. Trecento rivoltosi saranno confinati. Ad essi Mussolini conferirà la medaglia d’argento della sua Repubblica sociale. In via più generale, il libro sottolinea che l’attenzione riservata ai “clandestini” neo-fascisti operanti dietro le linee alleate, era già risuonata nel famoso ultimo discorso di Mussolini al Lirico di Milano: troveremo al Sud «più fascismo di quanto ne abbiamo lasciato». A questa "resistenza" fascista aveva dato un formidabile contributo ideale la distruzione del secolare monastero di Montecassino: avvenuto - per inesistenti necessità belliche degli Alleati - nonostante che i loro Monuments Officers fossero già operanti per tentare di preservare il nostro patrimonio artistico dalle offese di guerra. Dopo quella devastazione che provocò fortissima emozione nel mondo cattolico degli stessi Paesi alleati, la Repubblica Sociale Italiana emetterà una serie di francobolli con i danni arrecati dai bombardamenti a vari nostri monumenti, con la scritta hostium rabies diruit. Eventi e fermenti della tragedia nazionale, poco conosciuti: la storia del Sud sarà oscurata dagli eventi fondativi della Resistenza al Nord e della resa tedesca. Quasi a segnare funestamente l’inizio e la fine della guerra al Sud, ci saranno due catastrofi che colpiranno il porto di Bari, la prima “capitale” di quel Regno. Il bombardamento aereo tedesco del 2 dicembre 1943: considerato il maggior successo della Luftwaffe in tutta la guerra (venti grandi navi affondate e fra esse la nave alleata esplosa con un suo carico di iprite, coperto da disumano “segreto militare” che condusse alla morte “sconosciuta” centinaia di lavoratori portuali: mille vittime italiane, mille le alleate). E lo scoppio del piroscafo Henderson saltato in aria provocando quasi 400 vittime, ancora nella luttuosa prima linea i lavoratori portuali baresi: era il 9 aprile del 1945. Erano passati 19 mesi dall’8 settembre; mancavano 16 giorni al 25 aprile.
4. Per molti ragazzini del Regno del Sud il segno che la guerra fosse veramente finita e l’Italia riunificata, fu quando la Mondadori riprese, come se nulla fosse successo, il loro abbonamento a “Topolino” (anche se erano stati nel frattempo compensati dagli splendidi settimanali nati a Roma: “Il Vittorioso”, con i geniali fumetti di Jacovitti, e “L’Intrepido”). Già Fausto Coppi, reduce della prigionia, su una bicicletta regalatagli da un falegname di Somma Vesuviana, aveva fatto in tre giorni gli 800 chilometri che lo separavano da Napoli alla sua casa di Castellania. Riprendeva il campionato di calcio: ancora in due gironi con un turno finale unificato che vide le squadre del Nord largamente dominanti. A Napoli due creazioni artistiche erano state come il sigillo filosofico di una grande tragedia: Napoli milionaria di Eduardo de Filippo («Ha da passa’ a’ nuttata») e Simmo ‘e Napule paisà di Peppino Fiorelli («chi ha avuto, ha avuto, ha avuto /chi ha dato, ha dato, ha dato…scurdammoce ‘o passato»). Sembrava che con quelle parole di speranza e di pacificazione, il Sud volesse dare all’Italia intera il segnale di una Ricostruzione morale e materiale che cominciasse proprio lì, da Roma in giù. In fondo, le tante, dettagliate notizie contenute in questo libro ricordano che la politica, nella sua forma più alta, era rinata proprio lì. A Bari, prima, a Napoli e Salerno poi, una nuova concezione dell’Italia aveva preso forma. Erano tutti lì: da Benedetto Croce ad Aldo Moro, da Carlo Azeglio Ciampi a Michele Cifarelli, da Alcide De Gasperi a Palmiro Togliatti, da Tommaso Fiore a Corrado Alvaro, alla vivacissima Alba de Cespedes. Perfino la prima effervescenza dell’endemico populismo italiano era apparsa lì : con il grande successo dell’Uomo qualunque di Guglielmo Giannini. Ma c’era stato anche Giuseppe Di Vittorio, che con le lotte contadine, aveva offerto il primo esempio di un “sindacalismo” radicale e nazionale. Con responsabilità e pazienza, che oggi appaiono leggendarie, si erano gradualmente escogitate soluzioni istituzionali, che avrebbero assicurato la transizione legale dallo Stato monarchico a quello repubblicano. Nel Regno del Sud si era formato-come si è visto- il Corpo italiano di liberazione: l’unico punto di riferimento di quadri militari dopo l’armistizio che conferiva una qualche concretezza alla “cobelligeranza” contro il nazifascismo. Il mantenimento in vita di una certa idea di Patria. Radio Bari («qui parla Radio Bari, libera voce del governo d’Italia») e la Gazzetta del Mezzogiorno (l’unico giornale d’Italia a non sospendere le pubblicazioni neppure per un solo giorno in tutti gli anni di guerra, p. 379) furono le voci che attestarono che non tutto lo Stato era scomparso nella voragine delle invasioni. E che uno Stato c’era, con la sua legittimazione, di fronte alla Repubblica Sociale che sembrava attestare solo una reviviscenza del fascismo. Poi ci fu il “vento del Nord” che portò la grande ansia di rinnovamento di un Resistenza italiana connessa a quella europea. Certo, il Sud non fu dimenticato: anche se passarono 5 anni prima della creazione della Cassa per il Mezzogiorno di De Gasperi e Pasquale Saraceno (1950). Ma, anche dopo aver letto il libro di Avagliano e Palmieri, con il suo caleidoscopio di multiformi vicende, si ha la sensazione che poco o nulla fu fatto per mantenere al Meridione del Paese il ruolo “protagonista” con cui aveva affrontato le vicende belliche in cui fu tanto duramente coinvolto. E che avevano fatto constatare, con la vista lunga di Ugo La Malfa, proprio mentre la “politica” si spostava a Roma: «la guerra passata con violenza estrema ha disarticolato completamente un territorio povero, in alcune zone poverissimo» (p. 209). Certo, tante cose sono mutate da quei giorni lontani: ma di quel “protagonismo” non più ritrovato è forse un simbolo La Gazzetta del Mezzogiorno. Non aveva mai chiuso negli anni più bui. Ha chiuso il 1° agosto 2021.
(Rivista Giuridica del Mezzogiorno, 20 dicembre 2021)