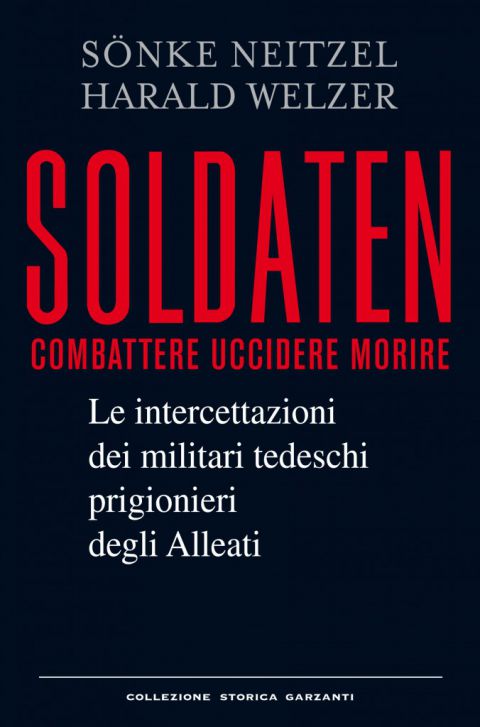«In Italia, in ogni posto dove arrivavamo, il tenente ci diceva sempre: “Per prima cosa facciamone fuori qualcuno!”. Diceva: “Allora, fatene fuori venti, così avremo un po’ di calma, che non si facciano strane idee!”. (Risate.) Tutti sulla piazza del mercato, poi arrivava uno con il mitra, rrr-rum, e tutti a terra. Così iniziava. Poi diceva: “Benissimo! Porci!”. Aveva una tale rabbia nei confronti degli italiani, da non crederci». A parlare è tale Sommer, caporale scelto della Wehrmacht. È una delle migliaia di conversazioni rubate dai servizi inglesi e americani grazie alle cimici nascoste durante la seconda guerra mondiale all’interno dei campi di prigionia alleati, registrate su vinile e trascritte in oltre 150 mila pagine di verbali, conservati ora negli archivi di stato di Londra e Washington.
Un campione di questa eccezionale documentazione è riprodotto nel saggio “Soldaten. Le intercettazioni dei militari tedeschi prigionieri degli Alleati”, in uscita nei prossimi giorni per i tipi della Garzanti (pp. 464, euro 24,50), curato in tandem dallo storico Sönke Neitzel e dallo psicologo Harald Welzer e già pubblicato in Germania. Per la prima volta due studiosi hanno potuto esaminare cosa pensavano realmente i soldati tedeschi della guerra. Un lavoro di ricerca straordinario.
Tra il 1939 e il 1945 ben diciotto milioni di tedeschi vengono chiamati alle armi nella Wehrmacht. L’interesse di questo saggio è che si tratta di gente comune, non di nazisti convinti arruolatisi nelle SS. Ma il ritratto che emerge da quelle conversazioni è ugualmente agghiacciante. Testimonia l’adesione spontanea alla guerra totale hitleriana di gran parte del popolo tedesco, che rifiutò fino quasi alla fine di credere a una sconfitta del Reich. E dimostra la fondatezza delle tesi di uno storico come Daniel Goldhagen sui “volenterosi carnefici” dell’esercito germanico, non meno violenti dei poliziotti delle SS. Demolendo definitivamente il mito di una Wehrmacht “pulita” e fatta da uomini d’onore, che non partecipò alle stragi di civili e non sapeva nulla della Shoah.
Leggendo i colloqui degli ufficiali e dei soldati tedeschi, che ignorano di essere ascoltati e quindi parlano senza inibizioni, non si può fare a meno di restare turbati, anche a quasi settant’anni di distanza. La brutalità, le torture, gli omicidi, la violenza, come scrivono i due autori, “sono il pane quotidiano di chi parla e di chi ascolta, non sono nulla di eccezionale. I soldati ne parlano per ore, così come discorrono, per esempio, di arerei, bombe, apparecchiature radar, città, paesaggi o donne”. Parafrasando Hannah Arendt, si potrebbe dire «la normalità del male».
Nei racconti di guerra (di tutti gli eserciti), le storie di fucilazioni, stupri e saccheggi appartengono alla quotidianità: quando se ne parla, non capita quasi mai che si arrivi a un confronto, che ci siano obiezioni di carattere morale o litigi. Ecco cosa dice Heinrich Skrzipek, timoniere dell’U-187: «Lo storpio va soppresso senza dolore. Così si fa. Loro non lo sanno, e comunque non hanno nulla nella vita. Basta però non essere teneri! Non siamo mica femminucce». Anzi, in molte narrazioni gli interlocutori fanno a gara a vantarsi di quella o quell’altra azione brutale.
La violenza sulle donne, ad esempio, è considerata un fatto normale. Parlando con un maresciallo della Luftwaffe degli aspetti turistici della campagna in Russia, un soldato infila un aneddoto terrificante: «belle da morire quelle ragazze. Ci passavamo accanto, le tiravamo dentro il camion, ce le sbattevamo e poi le buttavamo fuori di nuovo. Dovevi vedere come bestemmiavano!». E tra le risate del commilitone, continua a descrivere altri particolari del viaggio.
Anche lo sterminio degli ebrei non è un affare esclusivo delle SS. Dalle conversazioni emerge che molti soldati sono informati nel dettaglio di questi crimini e diverse unità della Wehrmacht partecipano, come esecutori, spettatori, complici, forse ausiliarie, alle fucilazioni di massa di ebrei nelle zone di occupazione. Peraltro la visione biologistica del mondo tipica del nazismo non è rivolta solo agli ebrei e colpisce sia i nemici («Non riesco a considerare i russi delle persone») che gli alleati giapponesi («Le scimmie gialle non sono essere umani, sono ancora bestie») e italiani («sono una razza stupida»).
A parte rare eccezioni (come avviene per i paracadutisti della Folgore), anche i soldati italiani vengono considerati in maniera assai negativa. «Una tragedia», «quegli italiani di merda (…) non fanno nulla», «non hanno nessuna voglia di guerreggiare», «non hanno alcuna fiducia in sé stessi», «se la fanno addosso». Pollice verso per gli ungheresi, considerati uno «schifo», e per gli americani, «vigliacchi e meschini», «rammolliti».
Certo, anche la Wehrmacht non è un blocco monolitico di opinioni e di pensiero. La maggior parte dei tedeschi si dichiara antisemita, ma c’è chi prova indignazione quando gli ebrei vengono fucilati. Alcuni sono antinazisti convinti, ma appoggiano apertamente la politica antiebraica di Hitler. C’è anche chi critica gli eccessi di violenza della Wehrmacht nei confronti dei civili, come il sergente maggiore Barth: «a Barletta hanno chiamato a raccolta la popolazione, dicendo che avrebbero distribuito i viveri, e invece hanno tirato fuori i mitra e hanno sparato, cose del genere hanno fatto. Poi, per strada, strappavano orologi e anelli, come i banditi». Non mancano prese di distanza radicali. Il sottufficiale Czerwenka arriva a dire: «Spesso mi sono vergognato di portare l’uniforme tedesca». Ma sono comunque eccezioni rispetto alla massa, che segue alla lettera, e non di rado ostentando un sottile piacere, i «protocolli del combattere, dell’uccidere e del morire».
(Il Mattino, 4 maggio 2012)




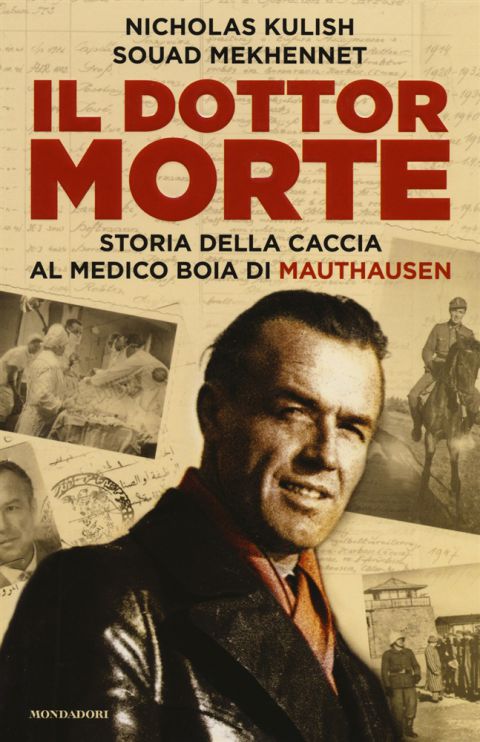

 Nel settembre 1979, il cinquantaseienne Benvenuti si mise in viaggio con la moglie a bordo di un camper per una sorta di via crucis, di pellegrinaggio laico e riparatore lungo le "stazioni" di Auschwitz, Terezín, Mauthausen-Gusen, Buchenwald, Dachau, Gonars, Monigo, Renicci, Banjica, Ravensbrück, Jasenovac, Belsen, Gürs, visitando archivi, musei, biblioteche del Vecchio continente, incontrando decine di sopravvissuti, recuperando testimonianze perdute e fotografando centinaia di disegni, per lo più realizzati dagli internati negli stessi lager con spezzoni di matita e su fogli di fortuna, qualcuno dipinto dai superstiti nell'immediato dopoguerra o da chi entrò nei campi come liberatore e volle fermare la memoria su carta.
Nel settembre 1979, il cinquantaseienne Benvenuti si mise in viaggio con la moglie a bordo di un camper per una sorta di via crucis, di pellegrinaggio laico e riparatore lungo le "stazioni" di Auschwitz, Terezín, Mauthausen-Gusen, Buchenwald, Dachau, Gonars, Monigo, Renicci, Banjica, Ravensbrück, Jasenovac, Belsen, Gürs, visitando archivi, musei, biblioteche del Vecchio continente, incontrando decine di sopravvissuti, recuperando testimonianze perdute e fotografando centinaia di disegni, per lo più realizzati dagli internati negli stessi lager con spezzoni di matita e su fogli di fortuna, qualcuno dipinto dai superstiti nell'immediato dopoguerra o da chi entrò nei campi come liberatore e volle fermare la memoria su carta.