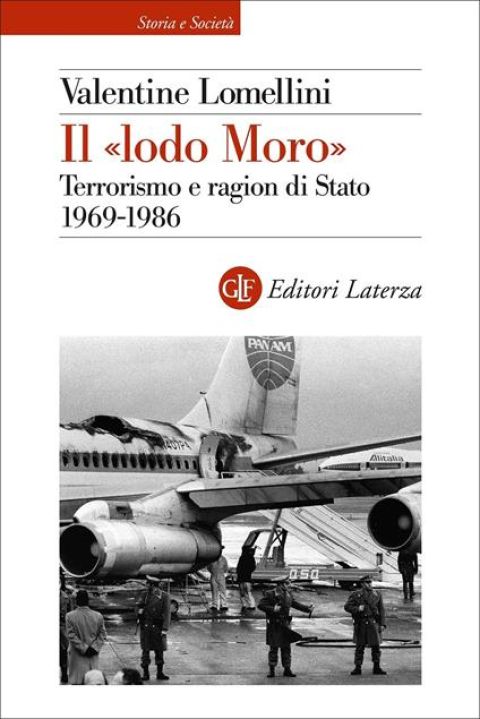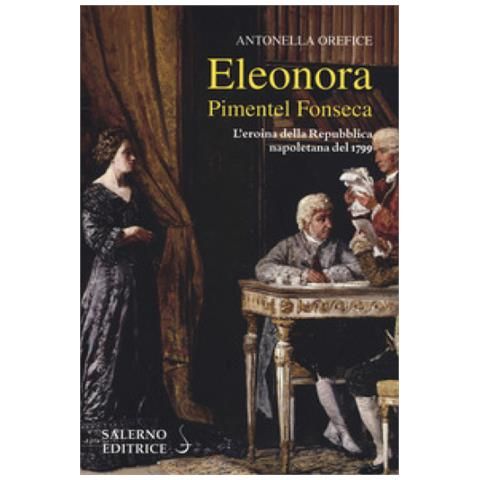Il lodo Moro. Terrorismo e ragion di Stato 1969-1986
di Mario Avagliano
Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, il terrorismo arabo-palestinese, a partire dalle stragi alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e all’aeroporto di Fiumicino del 1973, colpì l’Europa a più riprese con attentati, sequestri, dirottamenti di aerei e di navi. Alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, per scongiurare atti di violenza nel territorio nazionale strinsero patti segreti con i mandanti dei terroristi arabi, compreso alcuni Stati cosiddetti «canaglia». Patti che prevedevano il transito dei terroristi in Italia, il loro rilascio nel caso di arresto e perfino la vendita e la fornitura di armi alle dittature arabe. Rientra in questi accordi il caso Sigonella, quando il presidente del consiglio socialista Bettino Craxi rifiutò la consegna agli Stati Uniti sia del commando di terroristi palestinesi che tra il 7 e il 10 ottobre 1985 aveva dirottato la nave italiana Achille Lauro prendendo in ostaggio 511 persone e assassinando Leon Klinghoffer, un cittadino statunitense ebreo, sia di Abu Abbas, rappresentante dell’OLP che aveva mediato tra le autorità del Cairo e i terroristi.
È il tema del denso saggio di Valentine Lomellini, dal titolo Il «lodo Moro». Terrorismo e ragion di Stato 1969-1986, appena uscito in libreria per i tipi di Laterza. Il «lodo» non fu definito in un solo documento ma fu piuttosto un processo dinamico di negoziazione continua, che si adattò al mutare degli interlocutori coinvolti. Se, nonostante il perpetuo avvicendarsi dei governi della Repubblica, i nomi dei protagonisti italiani furono circoscritti, invece i soggetti terroristici mutarono in modo significativo: dapprima l’Organizzazione per la liberazione della Palestina di Arafat, in seguito un insieme frastagliato di movimenti estremisti e di mercenari, e infine gli Stati che li finanziavano: l’Iraq di Saddam Hussein, la Libia di Gheddafi e poi anche la Siria.
Dalla “prigione del popolo” dove era stato rinchiuso dalle Brigate rosse nel 1978, Aldo Moro chiedeva di trattare per la sua liberazione, svelando che questa era una prassi abituale per i terroristi palestinesi arrestati in Italia. In realtà, benché tale strategia venga attribuita allo statista democristiano, il patto per preservare l’Italia dagli attacchi del terrorismo internazionale coinvolse tutto l’apparato dello Stato, dai servizi segreti ai funzionari del Ministero degli Affari Esteri, del Viminale, del Ministero di Grazia e Giustizia, compreso la magistratura; nel 1976 fu implicato anche il presidente della Repubblica Giovanni Leone. All’inizio degli anni Ottanta, i governi Andreotti e Craxi confermarono l’operatività di questo accordo. Tra i pochi ad opporsi, moderatamente, a questa linea fu il repubblicano Giovanni Spadolini, che era più vicino ad Israele.
Perché, si chiede il saggio di Lomellini, esponenti di governo, talvolta di culture politiche diverse, scelsero questo compromesso, decidendo di fare ciò che con il terrorismo politico italiano, in particolare con le Brigate Rosse, venne da alcuni ritenuto inconcepibile?
Innanzitutto vi era una questione relativa all’obiettivo perseguito da queste organizzazioni e dagli Stati sponsor del terrorismo che, come scrive Lomellini, «esercitando pressioni sull’Italia, in sostanza chiedevano di spingersi un po’ più oltre rispetto ad una politica già in essere, quella filo-araba». La classe dirigente italiana poteva, inoltre, annoverare altre ragioni: innanzitutto la questione dell’approvvigionamento del petrolio (nel 1973 c’era stata la crisi petrolifera). Vi era poi un elemento correlato alla posizione geopolitica del Paese: vi fu, nella classe dirigente italiana, da Rumor a Moro, da Andreotti a Craxi, l’idea che solo il dialogo con quegli interlocutori avrebbe consentito di garantire la pace e soprattutto la stabilità sul fianco sud del Mediterraneo, oltre al timore che alcuni Paesi, come la Libia, potessero scivolare verso l’area di influenza dell’Unione Sovietica.
Nel medio periodo il sostegno all’ala moderata dell’OLP portò al rafforzamento, anche se altalenante, dei palestinesi disposti al dialogo; e sebbene l’emarginazione dei movimenti estremistici fu in parte compensata dal sostegno a loro offerto da alcuni Paesi arabi, l’apertura nei confronti dell’Iraq e soprattutto della Libia preservò la penisola dagli attacchi terroristici fino alla metà degli anni Ottanta, quando tale equilibrio si ruppe a causa dell’affermarsi della Siria come sostenitore dei gruppi terroristici mercenari ai margini della galassia palestinese.
Ma, come acutamente rileva Valentine Lomellini, «l’effetto di questo appeaseament nel lungo periodo è ancora da valutare: se e in che misura il terrorismo islamico del XXI secolo abbia appreso la lezione sull’efficacia della violenza politica come strumento di diplomazia della tensione, è un interrogativo che rimane aperto. La ragion di Stato aveva reso necessario il “lodo”, violando tuttavia il diritto dei cittadini italiani alla giustizia».
(Blog di Mario Avagliano, 2022)
- Pubblicato in Articoli