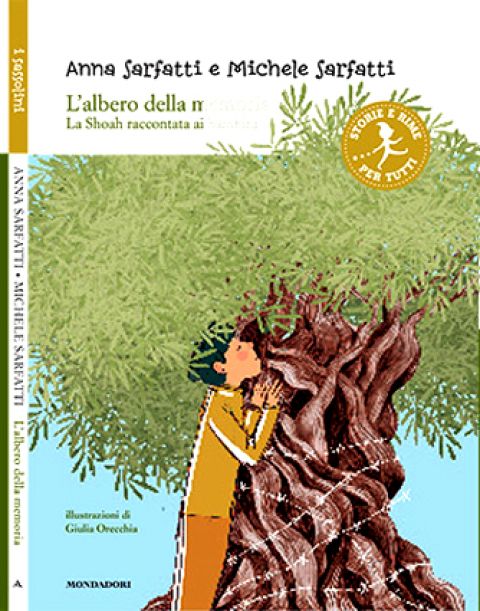Storie – La famiglia Klein-Sacerdoti e il pacchettino che attraversò la guerra
di Mario Avagliano
Ci sono microstorie della Shoah che commuovono e appassionano in modo particolare. Una di queste, è la vicenda della famiglia Klein-Sacerdoti, raccontata da Giorgio Sacerdoti nel libro Nel caso non ci rivedessimo (Archinto), con l’ausilio di lettere dell’epoca.
I Klein sono di Colonia, in Germania, i Sacerdoti originari di Modena, ma vivono a Milano. Il destino delle due famiglie s’incrocia nel 1939 su un campo da tennis a Parigi, dove sboccia l’amore tra il giovane Piero Sacerdoti, dipendente della Ras assicurazioni, e l’affascinante Ilse Klein, segretaria d’ufficio. I due si sposano il 14 agosto 1940 a Marsiglia, nella Francia del Sud occupata.
Sono tempi bui. L’Europa è sotto il segno della svastica e delle persecuzioni. Dopo la Notte dei Cristalli del novembre 1938, i genitori di Ilse, l’avvocato Siegmund Klien e la moglie Helene Meyer, decidono di riparare ad Amsterdam, dove si trova già l’altro figlio Walter. Da qui intrecciano una complicata corrispondenza con la figlia (il servizio postale tra Olanda e Francia del Sud è sospeso), per il tramite di una cugina di Helene che vive in Svizzera, Anni, che da Zurigo smista le lettere.
Negli anni successivi anche in Olanda, a seguito dell’occupazione nazista, la situazione degli ebrei precipita. Walter nel maggio 1942 tenta di fuggire a Marsiglia, per raggiungere la sorella, ma viene catturato dai nazisti al confine con la Francia. Le sue lettere dal carcere sono cariche di disperazione. Piero s’adopera in ogni modo per salvarlo, ma il suo destino è scritto e la mattina del 26 agosto il giovane viene deportato ad Auschwitz, assieme ad altri 948 sfortunati.
La madre Helene per il dolore si ammala e il 14 gennaio 1943 muore in un ospedale di campagna, dopo aver tentato il suicidio. Qualche settimana prima, però, assieme al marito, avendo saputo che la figlia Ilse è incinta, ha fatto in tempo a confezionare amorevolmente un pacchettino con il corredino per il nipotino in arrivo, Giorgio Sacerdoti. Il pacchetto attraversa l’Europa in guerra e, dato per disperso, dopo tre mesi giunge incredibilmente a destinazione, quando la donna è già morta.
La scomparsa di Helene verrà nascosta ad Ilse dal padre per quasi un anno. Solo il 16 ottobre papà Siegmund, che sente la fine vicina, chiederà ai parenti di rivelare la verità ad Ilse. Tre giorni dopo verrà arrestato e dopo un paio di cartoline dal campo di raccolta di Westerbok, anche lui caricato come una bestia su un convoglio per Auschwitz, dove morirà all’età di 69 anni.
Intanto la giovane coppia costituita da Piero ed Ilse, con il piccolo Giorgio nato a marzo, fugge da Nizza in un villino sul lago Maggiore, unendosi ai genitori Sacerdoti, papà Nino e mamma Gabriella. L’incubo non è finito. Dopo l’8 settembre, anche in Italia parte la caccia all’ebreo. I Sacerdoti riescono fortunosamente a passare la frontiera svizzera a Vieggiù e poi si trasferiscono a Ginevra, dove trovano la sospirata salvezza. Ma l’orrore di quegli anni e la perdita di mezza famiglia segnerà per sempre la loro vita.
(L'Unione Informa e portale moked.it del 3 settembre 2013)
- Pubblicato in Storie