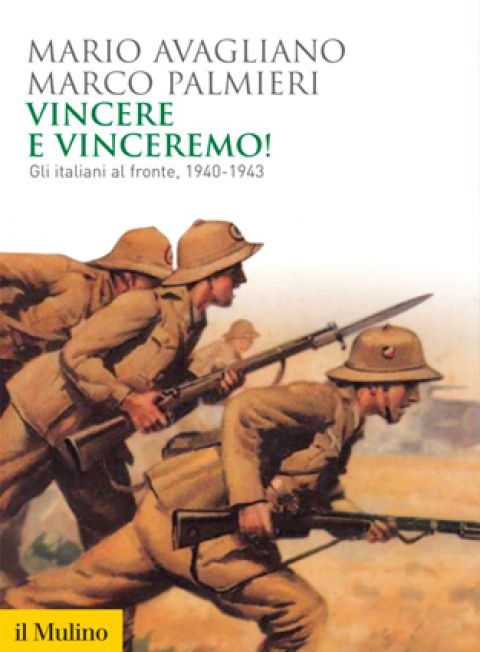di Anna Foa
Sono in questi giorni settantacinque anni dal grande bombardamento di Barcellona effettuato dall'aviazione italiana nel corso della guerra civile spagnola: dal 16 al 18 marzo 1938 migliaia di bombe si rovesciarono sulla città, uccidendo un migliaio di persone e scatenando il panico nella popolazione che si diede alla fuga. Lo ricordano in contemporanea il Corriere della Sera di ieri e lo spagnolo La Vanguardia, sottolineando anche come, dopo l'attacco del 1937 su Guernica da parte dell'aviazione nazista, fosse la seconda volta che la guerra contro i civili, tanto tipica del Novecento, si operava dall'alto, attraverso i bombardamenti.
Un tragico preludio a quello che sarebbe successo, prima ad opera dell'aviazione tedesca sull'Inghilterra, poi ad opera dell'aviazione anglo-americana sulle città tedesche, nella successiva guerra mondiale. Tali bombardamenti in effetti non colpivano i civili solo come conseguenza indesiderata ed inevitabile delle operazioni militari, ma li colpivano appositamente per demoralizzare il nemico e spingerlo alla resa. Quanto al bombardamento di Barcellona, fu il primo momento di quell'attiva partecipazione, da parte italiana, allla guerra portata da Hitler all'Europa intera, che avrebbe visto l'Italia di nuovo schierata accanto ai nazisti e che avrebbe visto tanti episodi terribili di guerra contro i civili, dal cielo e dalla terra. I "buoni italiani" però non hanno mai chiesto scusa di quel bombardamento, a differenza della Germania, dove nel 1997 il presidente tedesco si è scusato formalmente per il bombardamento di Guernica. Forse, sarebbe il caso di farlo ora. Meglio tardi che mai.
(L'Unione Informa, 18 marzo 2013)
L'articolo di Dino Messina
Il mito degli Italiani brava gente e il bombardamwento di Barcellona del marzo 1938
Che nei cieli e per le strade di Barcellona tra il 16 e il 18 marzo 1938 fosse avvenuto qualcosa di terribile gli italiani lo appresero subito attraverso le corrispondenze del “Corriere della sera”, il più diffuso giornale italiano, dal 1925 controllato dal regime. Già il 18 marzo il quotidiano milanese titolava: «Il popolo di Barcellona chiede la resa», il 20 avvertiva: «Barcellona abbandonata da centinaia di migliaia di abitanti — scene di terrore e di rivolta». E il 21: «Barcellona stremata». I corrispondenti come lo scrittore Guido Piovene o l’inviato Mario Massai sottolinearono la gravità dell’impatto che i bombardamenti dell’aviazione italiana avevano avuto sul corso della guerra ma si guardarono bene dal denunciare, come fece il Times di Londra, che almeno seicento abitanti in tre giorni avevano perso la vita (in realtà circa il doppio), tantissimi bambini, per lo più residenti nei quartieri popolari. Fu subito chiaro, insomma, che la strage non era stata causale ma voluta, per un preciso ordine arrivato all’improvviso da Benito Mussolini in persona. Tutto scritto, tutto documentato dalle cronache dell’epoca, nelle pagine del diario del ministro degli Esteri italiano e genero del Duce, Galeazzo Ciano, nei libri scritti dagli storici italiani, da Giorgio Rochat (“Le guerre italiane 1935-1943″) a Lucio Ceva, “Spagne 1936-1939″.
Eppure ben poco della verità sull’orrore scatenato dai bombardieri italiani decollati dalle Baleari con l’ordine preciso di colpire e seminare terrore è giunto alla nostra opinione pubblica. Per prendere coscienza delle responsabilità italiane nel primo “civil bombing” di una grande città europea forse occorrerebbe un atto pubblico simile a quello compiuto dal presidente tedesco Roman Herzog che nel 1997, nel sessantesimo anniversario di Guernica (26 aprile 1937), chiese scusa alla gente spagnola. Guernica-Barcellona un paragone azzardato? Nient’affatto. Altri se ne potrebbero fare. Per esempio con Durango, la cittadina della Vizcaya che il 31 marzo 1937 venne attaccata da squadriglie italiane che distrussero case e uccisero 289 persone. Barcellona tuttavia resta una pietra miliare del terrore e forse è venuto il momento, dopo aver analizzato per circa un ventennio gli effetti che la «guerra ai civili» ha avuto sul suolo italiano (dai rastrellamenti nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 ai bombardamenti dell’aviazione Alleata), che gli storici facessero uno sforzo pari in direzione diversa. Raccontarci, cioè, dall’Etiopia ai Balcani, dalla Grecia alla Spagna la guerra vista dalla parte delle vittime, con gli italiani nelle vesti di aggressori. Non che manchino studi di questo tipo, da Angelo del Boca in poi, ma si sente soprattutto in ambito divulgativo, una reticenza lontana. Quella che deriva dall’auto rappresentazione di «italiani brava gente», ma anche da una mancata Norimberga successiva al fascismo e, non ultimo, dal fatto di essere entrati nella Seconda guerra mondiale con una casacca e nell’esserne usciti con un’altra.
Il bombardamento di Barcellona, così come tutti gli altri atti di terrore dall’aria durante l’aggressione alla Repubblica spagnola, è il frutto ideologico, militare e politico di una storia tutta italiana. Il punto di vista militare e ideologico risale a Giulio Dohuet, che ben prima del britannico Hugh Trenchard, cioè negli anni Venti, con un’opera ancora oggi citata in tutti i manuali di strategia militare, “Il dominio dell’aria”, anticipò il concetto del «civil bombing»: «Immaginiamoci una grande città che, in pochi minuti, veda la sua parte centrale, per un raggio di 250 metri all’incirca, colpita da una massa di proiettili dal peso complessivo di una ventina di tonnellate…». Sembra la profezia di quanto sarebbe avvenuto a Barcellona dove i bombardieri Savoia Marchetti 79 in un paio di giorni sganciarono circa 44 tonnellate di esplosivi.
E a un’azione dimostrativa che seminasse terrore, come ha raccontato anche Edoardo Grassia, pensava Mussolini quando pochi minuti prima di pronunciare alla Camera il suo discorso in reazione all’Anschluss dell’Austria da parte delle truppe di Hitler, diede l’ordine al Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica di «iniziare azione violenta su Barcellona con martellamento diluito nel tempo». Nessuna consultazione con altri organismi militari, nemmeno con Franco. Fu una decisione di Mussolini per seminare terrore. E nelle intenzioni anche una cinica operazione mediatica per recuperare terreno rispetto all’iniziativa di Hitler e magari rimediare alla figuraccia ancora non dimenticata della disfatta di Guadalajara. La riprova delle intenzioni di Mussolini si ha nel diario di Galeazzo Ciano, quando annota la reazione del duce alle proteste di parte britannica: «Quando l’ho informato del passo di Perth (ambasciatore inglese a Roma, ndr), non se ne è molto preoccupato, anzi si è dichiarato lieto del fatto che gli italiani riescano a destare orrore per la loro aggressività anziché compiacimento come mandolinisti».
A Mussolini il progetto di trasformazione antropologica del popolo italiano non riuscì ma il fascismo portò «la brava gente» a macchiarsi di crimini di cui dobbiamo chiedere scusa.
(Corriere della Sera, 17 marzo 2013)