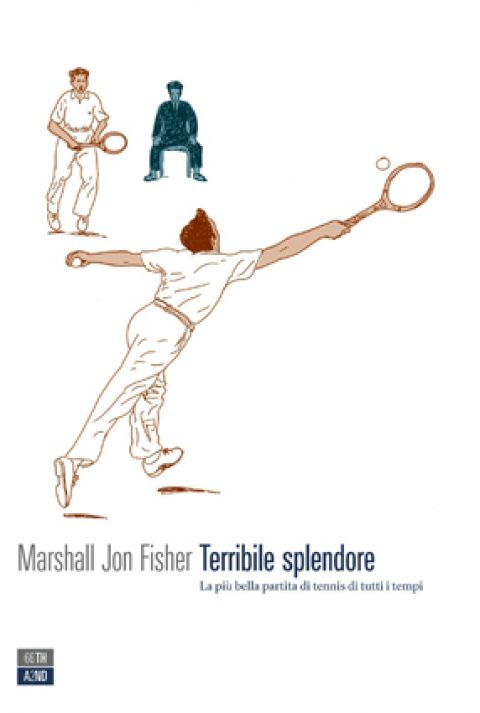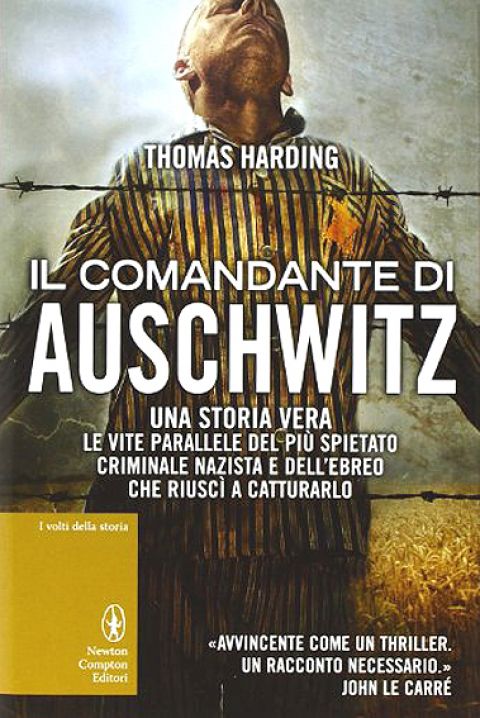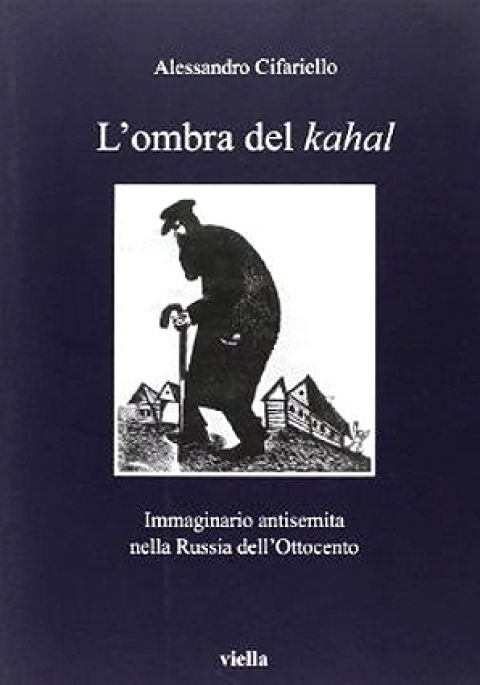Storie – La lunga strada sconosciuta
di Mario Avagliano
Tra il 1933 e il 1945 prima la persecuzione nazifascista e poi la seconda guerra mondiale separarono brutalmente molte famiglie di ebrei, costringendo i loro membri a cercare di sopravvivere in vari angoli d’Europa. E’ il caso di Hela Schein e di Otto e Heinz Skall, nonché di Willi Kleinberg e Gusti Mandler (rispettivamente secondo marito di Hela e seconda moglie di Otto), una famiglia ebrea “frammentata” in quegli anni tra Austria, Cecoslovacchia e Italia.
La loro vicenda è stata raccontata, con garbo e sensibilità, da Roberto Lughezzani nel bel libro La lunga strada sconosciuta. Una famiglia ebrea nella morsa del nazifascismo (Marlin editore).
La tragica storia ricalca quella di milioni di ebrei: nell’attesa angosciosa della fine, Willi muore di crepacuore, mentre Hela, deportata in Polonia, sparisce nell’orrore del lager; Otto con la seconda moglie Gusti si suicida a Praga per sfuggire alla deportazione a Theresienstadt.
L’unico sopravvissuto della famiglia è il giovane Heinz, figlio di Hela e di Otto, che ha studiato in Italia e dopo il varo delle leggi razziali finisce nel campo d’internamento di Campagna, e poi a Sala Consilina, in provincia di Salerno.
A Sala Consilina Heinz intreccia una tenera storia d’amore con una giovane insegnante, Rita Cairone, che sposerà dopo la guerra. Egli resterà fino all’ultimo il custode delle memorie familiari, il depositario delle lettere straordinarie che i suoi gli avevano scritto negli ultimi anni di vita. Sono lettere che si leggono con viva commozione e, contro ogni forma di negazionismo, testimoniano la ferocia con cui il nazismo infierì su milioni di esseri umani, di null’altro colpevoli che di essere ebrei.
(L'Unione Informa, 11 giugno 2013 e portale Moked.it)
Roberto Lughezzani "La lunga strada sconosciuta"
Una famiglia ebrea nella morsa del nazifascismo
Presentazione di Elena Skall
Ft. 12,2 x 20
pp. 228€ 16,00
ISBN 978-88-6043-079-3
- Pubblicato in Storie