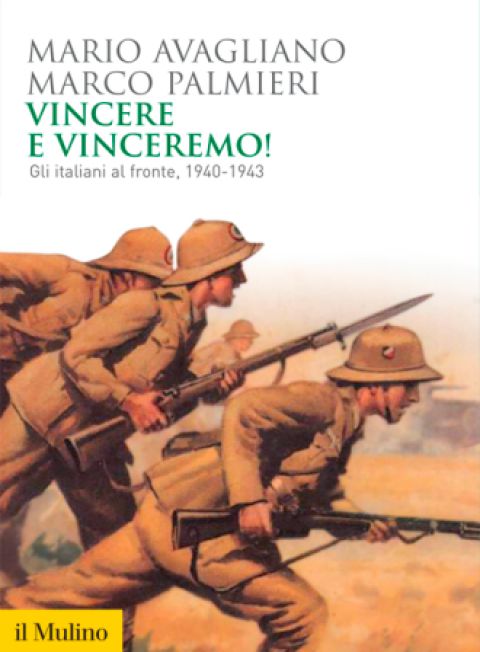Patria, coraggio, illusioni: le parole degli italiani dal fronte
di Fabio Isman
Mica tanto «brava gente»: le lettere degli italiani mandati sui fronti della seconda guerra mondiale ne dimostrano, per un buon tratto, la sostanziale accettazione del conflitto, e di chi l’aveva voluto; le prime resipiscenze, soprattutto sulle sorti belliche, cominciano ad affiorare già verso il tardo 1940 (ma la censura le blocca: non le fa arrivare ai famigliari dei mittenti); e soltanto nelle ultime settimane del fascismo, a metà del 1943, la critica si fa più aperta. Ma prima, è quasi soltanto «vincere e vinceremo», «spezzare le reni alla Grecia », una rivalsa verso le demoplutocrazie (così vengono chiamate, perfino dai teatri di guerra).
Due bravi ricercatori, Mario Avagliano e Marco Palmieri, hanno scandagliato ogni possibile fonte, anche tra le missive che la censura ha stoppato, e ne hanno tratto un compendio e un campionario assai ricchi e doviziosi: 375 pagine d’un libro (Vincere e vinceremo! Gli italiani al fronte, 1940-1943 Il Mulino ed.) che si legge tutto d’un fiato, e racconta tante singolarità.

L’«ora delle decisioni irrevocabili» affascina molti, e reprime ogni dubbio: anche se gli aerei, come il trimotore Savoia-Marchetti, sono solo «scatole di sardine»; anche se mancano i carri, e si va in regioni fredde vestiti di tela. Ma «tra pochi mesi sarò accanto a te»: l’italiano è ancora poco diffuso. L’attimo dell’attacco è solenne; lo è anche per Genserico Fontana, ufficiale dei granatieri che a Campo Imperatore, a luglio ’43, custodirà Mussolini a Campo Imperatore; e poi, terminerà la vita alle Fosse Ardeatine.
ANGOSCE
Si cerca di tranquillizzare chi sta a casa; dopo, saranno le angosce perché la guerra è arrivata anche nella Penisola. Se si racconta troppo, la lettera non arriva. Quando si limita soltanto alle speranze e agli slogan, invece sì. «Arriverà il giorno in cui le nostre forze e il nostro ardimento vendicheranno i nostri morti e feriti». Sarà una prolungata illusione: in Africa, in Grecia, e perfino in Russia. Caldo, «pidocchi, l’eterna scatoletta e galletta, i due litri di acqua al giorno che talora puzzano di benzina» non bastano, a lungo, per la presa di coscienza. L’Inghilterra resta la «oscena mantenuta col sangue e l’oro altrui», perché tanto profondo è stato l’indottrinamento. Anche dalla prigionia, sono in pochi ad ammettere che «sono trattato benissimo e ben curato; gli inglesi sono gentili, mi trattano in guanti bianchi, meglio degli italiani» (ma a casa non leggeranno). Va avanti così, magari con «i rossi cui far vedere i sorci verdi», fin quasi alla vigilia della disfatta: il soldato crede di essere il milite di uno scontro tra civiltà. E la sua, s’intende, è quella «giusta»: deve «imporsi ».
Fino al 1943, i tedeschi sono «camerati» affidabili. In Russia è la svolta. «La morte è in agguato ad ogni angolo», scrive il tenente geniere Ezo Gilardino: l’indomani, non ci sarà più. Drammatici i racconti dal «generale inverno»; non ce la fa più a contenerli perfino la stessa diga della censura.
Chi era partito con entusiasmo e convinzione, li perde. Arriva ormai ben altro, dai fronti, che gli
slogan di pochi anni prima. Non è soltanto la voglia, sempre più prorompente, di tornare a casa: comincia già l’antifascismo. Il generale Giulio Tamassia scrive che «fa impressione questo abbandono improvviso di tutti i più accesi sostenitori del fascismo»: anche dalle ceneri di una guerra assai mal combattuta, dalle sofferenze di mille soldati assai mal in arnese, sta nascendo la nuova Italia.
(Il Messaggero, 13 gennaio 2015)
- Pubblicato in Recensioni
- 0

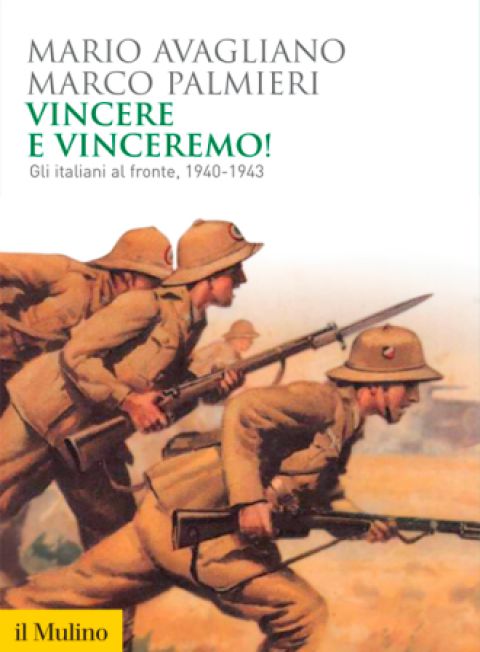


 Nel settembre 1979, il cinquantaseienne Benvenuti si mise in viaggio con la moglie a bordo di un camper per una sorta di via crucis, di pellegrinaggio laico e riparatore lungo le "stazioni" di Auschwitz, Terezín, Mauthausen-Gusen, Buchenwald, Dachau, Gonars, Monigo, Renicci, Banjica, Ravensbrück, Jasenovac, Belsen, Gürs, visitando archivi, musei, biblioteche del Vecchio continente, incontrando decine di sopravvissuti, recuperando testimonianze perdute e fotografando centinaia di disegni, per lo più realizzati dagli internati negli stessi lager con spezzoni di matita e su fogli di fortuna, qualcuno dipinto dai superstiti nell'immediato dopoguerra o da chi entrò nei campi come liberatore e volle fermare la memoria su carta.
Nel settembre 1979, il cinquantaseienne Benvenuti si mise in viaggio con la moglie a bordo di un camper per una sorta di via crucis, di pellegrinaggio laico e riparatore lungo le "stazioni" di Auschwitz, Terezín, Mauthausen-Gusen, Buchenwald, Dachau, Gonars, Monigo, Renicci, Banjica, Ravensbrück, Jasenovac, Belsen, Gürs, visitando archivi, musei, biblioteche del Vecchio continente, incontrando decine di sopravvissuti, recuperando testimonianze perdute e fotografando centinaia di disegni, per lo più realizzati dagli internati negli stessi lager con spezzoni di matita e su fogli di fortuna, qualcuno dipinto dai superstiti nell'immediato dopoguerra o da chi entrò nei campi come liberatore e volle fermare la memoria su carta.