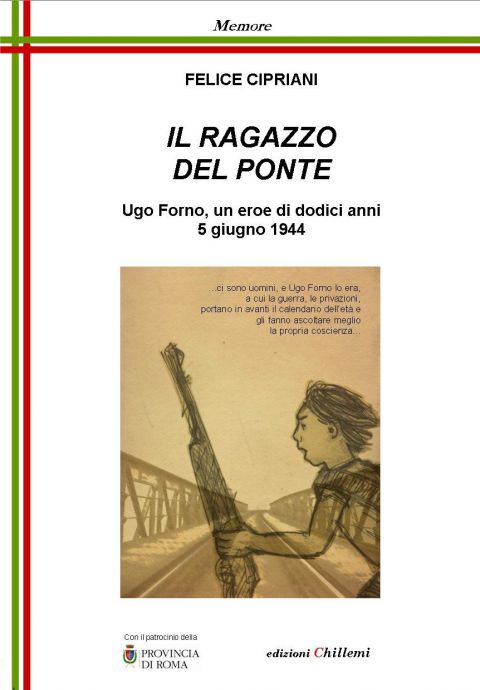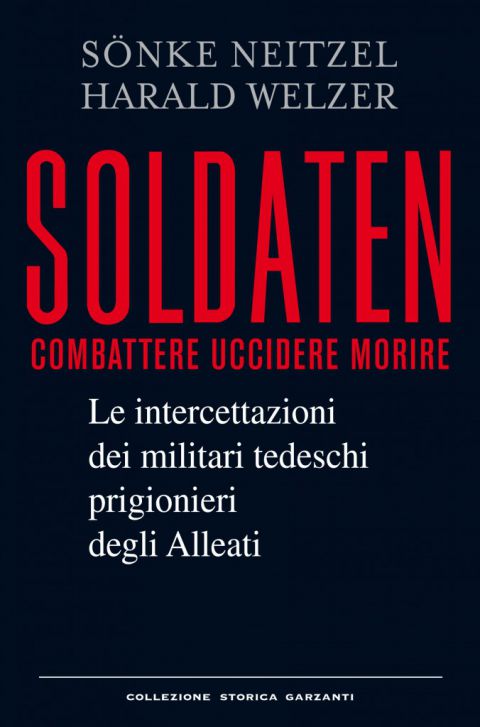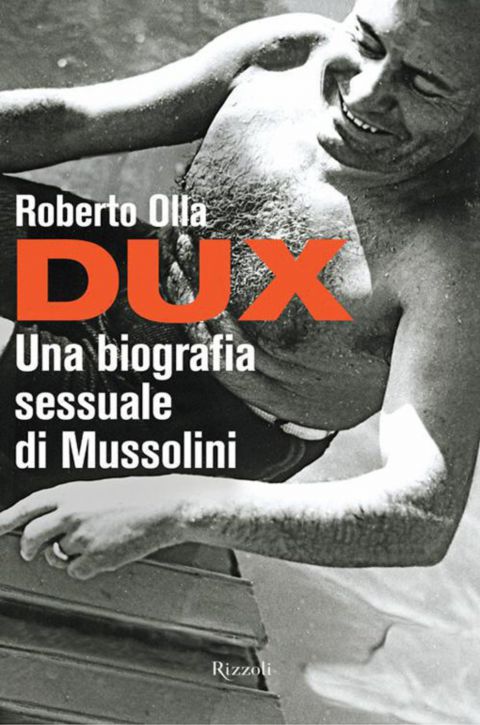Eroe. Il dodicenne romano che fermò la Wehrmacht.
Eroe. Il dodicenne romano che fermò la Wehrmacht. La storia di Ugo Forno, l’ultimo caduto della capitale, proposto ora per una medaglia
di Mario Avagliano
Roma, ponte ferroviario sull’Aniene. Sui binari di ferro sfrecciano come fulmini i treni rossi dell’Alta velocità. Una pista ciclabile s’inoltra nel verde, accanto al fiume. Sembra lontano il 5 giugno del 1944, quando sotto il sole cocente della primavera romana il dodicenne Ugo Forno, gracile ma vivacissimo, con i capelli scuri e gli occhi azzurri, morì per difendere il viadotto dagli ordigni germanici, mettendo in fuga assieme ad altri ragazzi e ad alcuni contadini i sabotatori della Wehrmacht. In memoria di quel suo coraggioso gesto la Presidenza della Repubblica ha avviato la procedura per l’attribuzione della medaglia d’oro al valor civile.
La breve vita dell’ultimo resistente romano è stata raccontata da Felice Cipriani nel saggio “Il Ragazzo del Ponte. Ugo Forno eroe dodicenne. Roma 5 Giugno 1944” (edizioni Chillemi), che sarà presentato il 29 maggio alla Provincia di Roma e sarà nelle librerie all’inizio del prossimo mese. Cipriani, completando il lavoro di ricerca realizzato da Cesare De Simone in “Roma Città prigioniera”, ha recuperato la documentazione conservata presso l’Archivio centrale di Stato di Roma, intervistando il fratello Francesco Forno, il compagno di banco Antonino Gargiulo e altri testimoni dell’epoca.
Ughetto, nato il 27 aprile del 1932 a Roma dai siciliani Enea Angelo Forno, impiegato dell’intendenza di Finanza, e Maria Vittoria, abitava al civico 15 di via Nemorense ed era studente al secondo anno, sezione B, della scuola media “Luigi Settembrini”, che ha la sede accanto al liceo classico “Giulio Cesare” di Corso Trieste. Amava i fumetti, divorava gli albi di Flash Gordon e del Vittorioso e, come tutti i ragazzi della sua età, durante il Ventennio aveva vestito la divisa dei Figli della Lupa e dei Balilla. Ma la sua famiglia era animata da sentimenti antifascisti. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il padre Enea era diventato collaboratore del Fronte militare clandestino diretto da Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, che tesseva le file della resistenza militare e monarchica ai tedeschi nella capitale.
Quel 5 giugno del 1944, giorno di festeggiamenti a Roma per la liberazione dall’occupazione nazifascista, alle 6,30 del mattino lo studente era già a Piazza Verbano, “Ugo era sereno girava tra le Jeep dei soldati americani, aveva un paio di pantaloncini corti ed una maglietta, con sé non aveva nulla”, ricorda il compagno di banco della scuola elementare. Alle 7,30 Angiolo Bandinelli, che diverrà parlamentare radicale, lo vide in mezzo a delle persone, tra via Ceresio e via Nemorense, mentre gridava: ”C’è una battaglia, lassù oltre piazza Vescovio! Ci sono i tedeschi, resistono ancora”.
Ughetto si allontanò verso piazza Vescovio, dirigendosi con altri giovani armati di fucili, tra cui il sottotenente paracadutista Giovanni Allegra, verso lo strapiombo sull’Aniene. Sotto il ponte gli artificieri della Wehrmacht stavano collocando le cariche esplosive.
Si accese uno scontro a fuoco. Ugo e i suoi amici chiesero aiuto ai contadini della casa colonica e assieme spararono in direzione dei tedeschi. I guastatori della Wehrmacht, sorpresi, furono costretti ad abbandonare l’operazione di sabotaggio.
La loro ritirata fu “coperta” da un mortaio che iniziò a lanciare devastanti colpi verso gli italiani. Il primo colpì Francesco Guidi, figlio del proprietario dei terreni della zona (poi morirà in ospedale).
Ughetto, imbracciando il fucile, alto quasi quanto lui, invitò i compagni a sparare verso il punto da dove si vedeva il fumo provocato dal mortaio. Le schegge ed i spezzoni del secondo colpo ferirono ad una coscia Luciano Curzi e troncarono un braccio a Sandro Fornari, entrambi braccianti. Il terzo colpo fu mortale per il ragazzo, che fu preso alla testa e al petto e stramazzò al suolo morente.
A quel punto i tedeschi bruciarono il deposito di carburanti e fuggirono precipitosamente verso la via Salaria. Proprio mentre arrivavano sul posto due carri armati americani e alcuni gappisti comunisti.
Il sottotenente Allegra si chinò su Ugo e gli chiuse le palpebre sugli occhi sbarrati, avvolgendo il suo corpo esamine in una bandiera tricolore stracciata. Nel taschino gli verrà trovato un santino intriso di sangue.
Il ponte sull’Aniene (che dal 2010 porta il suo nome, su iniziativa meritoria di Ferrovie dello Stato) era salvo, con le micce degli ordigni ancora penzolanti. Ughetto fu l’ultimo caduto della resistenza nella capitale. Viene in mente un parallelo con un altro dodicenne romano, come osserva Paolo Conti nella breve ma incisiva prefazione del volume, “quel Righetto di Trastevere che, nelle ore più tragiche della gloriosa Repubblica Romana del 1849, rimane dilaniato da una bomba francese che lui stesso tenta di disinnescare come ha già fatto tante altre volte (bastava spegnere la miccia con uno straccio bagnato). Anche Righetto, come Ughetto, lotta contro un invasore”.