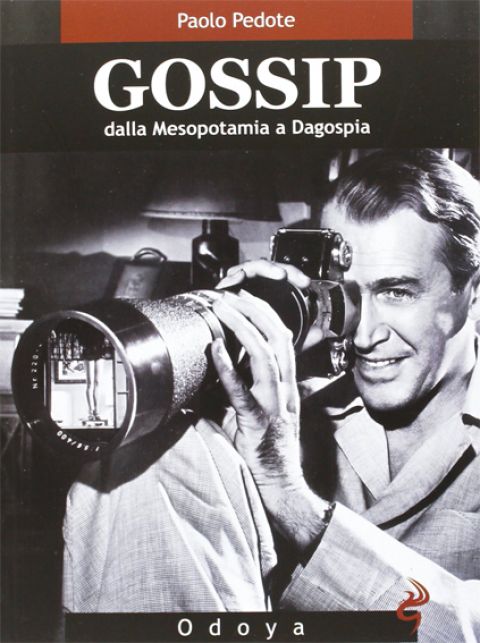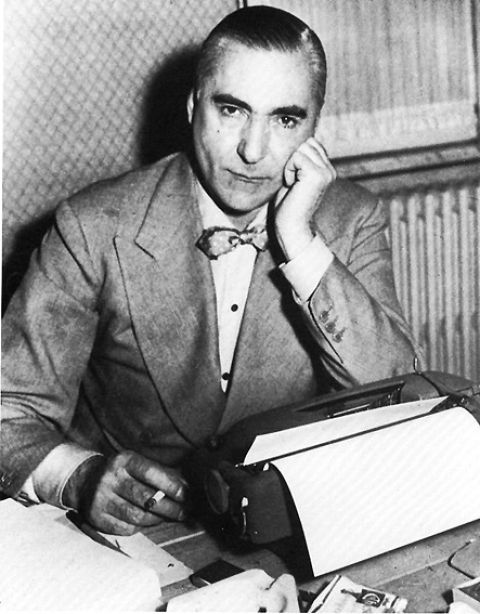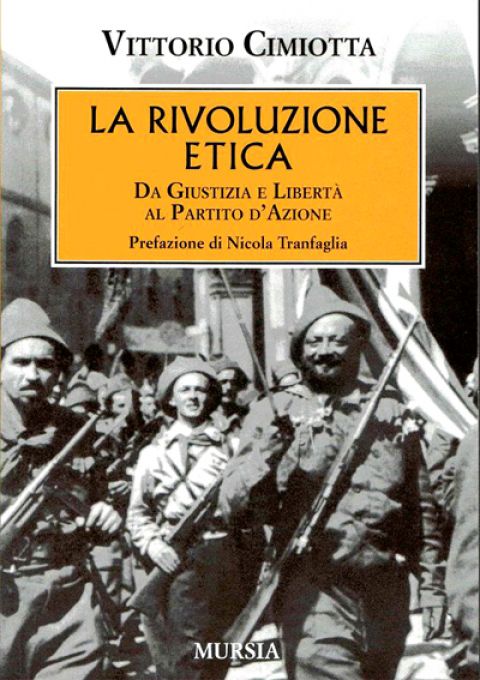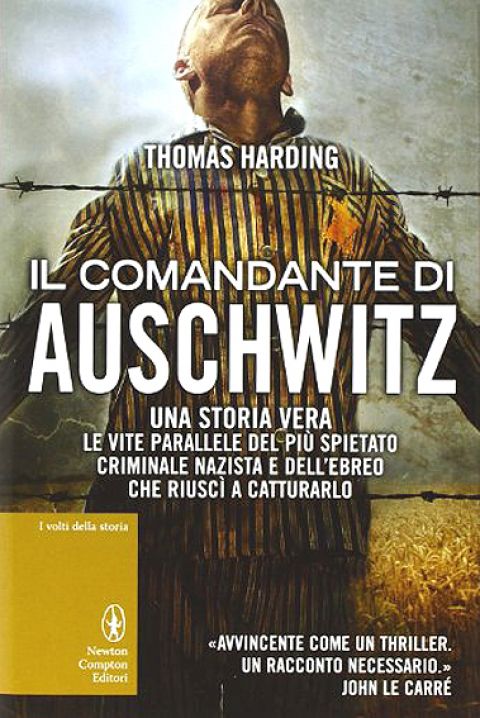Quel geroglifico è un gossip. Storia del pettegolezzo
di Mario Avagliano
“E’ assolutamente mostruoso ciò che la gente fa al giorno d’oggi mentre passeggia: dire, alle spalle degli altri, delle cose che sono assolutamente vere”, scriveva Oscar Wilde. Religiosi, storici, filosofi, poeti, corvi, cronisti, diaristi, memorialisti, letterati, politici, scrittori, principesse. Nell’arco dei secoli il gossip ha avuto molti protagonisti, molte facce e molte identità. E la sua funzione non è stata sempre negativa, anzi storicamente è servito a mettere alla berlina gli eccessi del potere politico, economico o religioso. Proprio grazie alle sue caratteristiche, riassunte nella famosa aria rossiniana La calunnia è un venticello: “Piano piano, terra terra / Sotto voce sibilando, / Va scorrendo, va ronzando; / Nelle orecchie della gente / S’introduce destramente, / E le teste ed i cervelli / Fa stordire e fa gonfiar”. La storia del pettegolezzo o, se si preferisce, del rumor, come lo definiscono sociologi, antropologi e psicologi (parola latina diventata rumour in inglese britannico), è quindi la storia di uno dei vizi più antichi e più diffusi del mondo, come ci racconta il documentato saggio di Paolo Pedote, intitolato Gossip dalla Mesopotamia a Dagospia (Odoya, pp. 284, euro 18).
La tesi dell’antropologo Robin Dunbar, che ha studiato alcuni insediamenti di ominidi di 250 mila anni fa, è che l’uomo ha sempre favorito e promosso il pettegolezzo, fin dalla notte dei tempi. Facendo un rapido excursus storico, troviamo infatti forme primordiali di gossip nelle caverne e nei geroglifici, ma anche nella Bibbia (se ne parla per la prima volta verso la fine della Genesi, in un racconto legato alla discendenza di Giacobbe) e nel Nuovo Testamento, nel quale la maldicenza viene utilizzata contro Gesù di Nazareth dai suoi nemici.
I romani furono maestri del gossip. Celebri le frasi erotiche ritrovate sulle mura di Pompei, del tipo “Votate per Isidoro all’edilizia. Lecca la fica in modo strepitoso”. La letteratura latina utilizzò fin dall’inizio le voci di corridoio per intrecciare l’elemento politico (d’accusa e di critica) con quello poetico, deridendo le grandi cariche imperiali. Ne costituiscono un esempio mirabile i carmina triumphalia, che i legionari improvvisavano durante le cerimonie di vittoria. Come quelli piccanti che i soldati cantarono durante il trionfo di Giulio Cesare sui Galli, per sottolineare la sua relazione omosessuale con Nicomede IV Filopatore, l’ultimo re di Bitinia: “Cesare ha sottomesso le Gallie, Nicomede ha sottomesso Cesare. Ecco, ora trionfa Cesare, che sottomise le Gallie, ora trionfa. Nicomede che ha sottomesso Cesare, non riporta nessun trionfo”.
Il primo grande scrittore di gossip della storia è stato Gaio Svetonio Tranquillo, che nei suoi libri ha tramandato le storie segrete di dodici imperatori romani, raccontando del rapporto incestuoso di Caligola con la sorella Drusilla; delle strategie d’amore della regina Cleopatra, dalla voce suadente e dall’aspetto seducente, amante di Giulio Cesare e di Marco Antonio; delle avventure notturne di Messalina, moglie dell’imperatore Claudio, che appena poteva scappava verso le periferie della città e, sotto il nome d’arte di Licisca, si prostituiva con marinai e gladiatori.
Il pettegolezzo, racconta il saggio di Pedote, ha poi attraversato il Medioevo, svelando le nefandezze dei papi libertini (vedi il capitolo sulla Sacre e segrete stanze), per vestirsi dopo l’anno Mille da cantastorie, menestrello e giullare. Alla nascita della letteratura italiana, si è insinuato nella Divina Commedia di Dante e nella novella boccaccesca, ed è diventato la prova schiacciante nei processi dell’Inquisizione. Pettegoli sono stati grandi personaggi del Cinquecento come Niccolo Machiavelli, Francesco Guicciardini e Pietro Aretino, e principesse alla corte settecentesca di Luigi XIV.
Dopo l’invenzione della stampa periodica, il gossip ha fatto il suo ingresso nel giornalismo. Nell’Ottocento nascono le grandi riviste di costume come l’inossidabile Vanity Fair, e nel Novecento lo star system hollywoodiano inventa i columnists, che tengono in pugno le carriere dei divi più famosi. I pettegolezzi tornano in auge durante le dittature e la Guerra Fredda, ancora una volta per mezzo della delazione. Nel dopoguerra, con la dolce vita ecco arrivare il paparazzo; poi, con la rivoluzione sessuale e un rinnovato “comune senso del pudore”, il gossip diventa protagonista assoluto di riviste che si sfidano a colpi di esclusive milionarie.
Gli anni Novanta ci lasciano con il primo sexgate della storia, l’affaire Clinton-Lewinsky, e con il Grande Fratello, una trasmissione che è l’emblema del pettegolezzo. Oggi viviamo in un’era dai ruoli invertiti: in cui spesso sono i vip che inseguono il gossip, per sopravvivere. E il pettegolezzo è protagonista dell’informazione televisiva, della stampa di alto e basso livello e dei reality show. Si parla di gossip persino quando ci riferiamo a documenti segreti e alle indiscrezioni di Wikileaks e Vatileaks. Si fa gossip in politica, nel mondo della finanza e del business. E, nell’era della “multimedialità”, si fa gossip in modo ossessivo su internet, dai social network a you tube. Ma non è più l’epoca di Gaio Svetonio, di Dante, delle pasquinate o, per andare a tempi più recenti, dei Fellini, dei Flaiano o dei Pasolini. Non c’è più critica, in senso hegeliano. Come osserva Paolo Pedote, “ci sono solo i protagonisti di un potere che si alimenta attraverso l’arroganza dell’esserci a tutti i costi”. Il gossip è diventato “la cornice di un fermo/vuoto immagine che caratterizza la nostra contemporaneità”.
(Pubblicato in una versione più breve su Il Messaggero, 4 agosto 2013)
- Pubblicato in Articoli